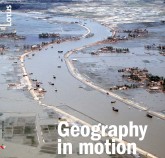in Lotus International n.145, 2011
Il referente come elemento del mondo reale o concetto cui un’espressione formale fa riferimento sta riapparendo nei contenuti dell’architettura. La nuova tendenza – fare cose utili e significative con pochi mezzi – è sicuramente caratterizzata da un lavoro attento alle esigenze delle persone, alle abitudini di una comunità, alle condizioni materiali di una situazione, ed è un lavoro di una nuova generazione di architetti, planners e paesaggisti che ha prodotto esempi contraddistinti dall’impiego consapevole di approcci alla prefabbricazione, alle tecnologie, al design modulare ecc. con una chiara attitudine politica, sociale, ma anche ecologica, economica ed estetica. Per ora questo nuovo dinamismo trova i suoi ambiti principali d’azione in zone rurali o periurbane, in aree povere e principalmente in alcuni paesi: dell’Estremo oriente, dell’Africa e dell’America latina. Lotus se ne sta occupando da tempo (vedi il progetto di Diébédo Francis Kéré, in cui l’intera comunità ha partecipato alla costruzione di una scuola in Burkina Faso; la sensibilizzazione della comunità in un processo culturale, nel Museum of Struggle in Sudafrica progettato da Noero Wolff, le case nella banlieue parigina di Lacaton e Vassal, gli interventi in Alabama di Rural Studio.….). Un caso limite è la nuova relazione che gli architetti cercano di stabilire con gli insediamenti marginali, come le favelas, che erano visti, o meglio non visti, soltanto come ambiti problematici di cui si andava sottolineando l’assenza di regole, la povertà, l’anarchia, la mancanza di comfort e di servizi. La svolta recente nell’approccio a queste realtà è incentrata nel riconoscere in questi ambiti la fonte di nuove esperienze, anche estetiche, se non di apprendimento e addirittura di riflessione sulle teorie dell’insediamento e nello scoprire l’occasione per stipulare degli accordi inediti frutto dell’incontro tra la popolazione e gli attori degli interventi. E’ da notare come la novità di queste tendenze consista dopotutto nel sollecitare l’architettura a riprendere un compito abbastanza ovvio di strumento per migliorare le condizioni sociali, politiche ed economiche di un luogo sia con il coinvolgimento degli interessati nel processo progettuale e costruttivo, sia con la sensibilizzazione della comunità in un processo culturale emancipativo. Una sottolineatura scontata per l’architettura se non si tenesse conto dei clamori e del genere di performances architettoniche cui la comunità degli architetti e il pubblico dei media sono stati sottoposti negli ultimi decenni.
Credo che molti architetti dei nostri paesi affluenti vedranno con un sospiro di sollievo la bellezza di questi edifici volti a soddisfare qualche bisogno, potranno persino maturare il desiderio romantico di trovarsi in posti dove il lavoro sembra avere un senso e, in una sorta di capovolgimento dei valori stabiliti, se interrogati, potrebbero dire di preferire i rapporti complicati con una comunità africana piuttosto che con le richieste di un loro avido developer. Circa le manifestazioni del nuovo atteggiamento e per evitare l’insorgere di equivoci in considerazione di certi luoghi comuni su molti paesi ‘esotici’ in cui il fenomeno si sta diffondendo, occorre precisare innanzitutto quello che esso non è. Innanzitutto non va rubricato come “architettura vernacolare’ alla maniera di Paul Oliver che la definisce semplicemente come architettura ‘del popolo’ e non fatta ‘per’ il popolo da professionisti commerciali. L’idea di ‘architettura senza architetti’ è stata diffusa da Bernard Rudofsky (1905 – 1988) con la mostra del 1964 al Museum of Modern Art di New York: la mostra presupponeva un approccio antropologico, un metodo etnografico nel senso classico di insieme di costumi, o di modelli di comportamento anziché, come si crede oggi dopo la critica all’etnografia classica, come una costruzione dell’antropologo e non un dato oggettivo e indipendente. Da quando l’antropologia entra nella sua fase postmoderna e decostruzionista il concetto di cultura viene definitivamente messo da parte, e il vero oggetto dell’antropologia è l’antropologo stesso, o meglio il suo io narrante e l’argomento attuale della critica alla mostra di Rudofsky è diventato quello di analizzare la scrittura e la costruzione di questo testo, le costruzioni retoriche e le strategie attuate dall’antropologo nel suo studio dove avviene la costruzione dell’altro. Nel caso di Rudofsky con finzione etnografica si intenderebbe non tanto che questa etnografia è falsa, bensì che è stata costruita, fabbricata a tavolino e come tale è parziale perché inevitabilmente basata sulla selezione e l’esclusione, tenendo conto, ad esempio, dell’influenza giovanile – per parlare della figura dell’etnografo – esercitata sul giovane studente dal viaggio nell’isola greca di Santorini in cui subì un fascino basato sull’idea che gli edifici fossero il risultato di vecchie tradizioni trasmesse di generazione in generazione senza contributo di architetti. Una fascinazione che è all’origine dell’idea dell’architettura indigena o vernacolare e del suo sviluppo ‘spontaneo’. Il fascino vernacolare dipende allora dal credere possibile il darsi del frutto spontaneo di una tradizione fuori dalla storia e dalle contraddizioni del nostro mondo sviluppato.
La nuova tendenza architettonica di cui stiamo trattando non corrisponde neppure ad un’ennesima edizione del tradizionalismo: non siamo certo di fronte ad una versione particolare del tradizionalismo anacronistico di certa architettura ‘colta’ che si offre ad una lettura contrastante le correnti dell’ architettura modernista. E neppure gli esempi della nuova tendenza andrebbero interpretati seguendo i canoni del contestualismo, così come è stato definito nei paesi europei con le sue preoccupazioni volte soprattutto alla salvaguardia di ambiti urbani e paesaggistici già costituiti. In questa nuova generazione di architetti si nota con una certa chiarezza la condizione operativa di una «postmodernità etnografica» che ci restituisce una visione meno pessimistica di un futuro collettivo, fatto di sempre più intensi scambi simbolici e contatti tra identità culturali frammentate e diverse. Questi architetti non sembrano disorientati in mezzo a tradizioni culturali disgregate o vittime di un’instabilità e di uno sradicamento che sono ormai un destino comune. Da quella che potrebbe apparire una catastrofica perdita di autenticità e purezza, emerge la possibilità di una indefinita ricomponibilità degli antichi oggetti culturali in strutture dotate di nuovo senso. Questa ripresa in chiave postmoderna e postcoloniale di un atteggiamento etnografico appare davvero notevole nell’attuale situazione del dibattito architettonico e vien da pensare con rammarico all’affrettata liquidazione all’università di Delft da parte dei giovani adepti della setta di Rem Koolhaas della figura di quell’architetto antropologo moderno che fu Aldo Van Eyck, con le sue ricerche degli strumenti più radicati nella definizione dell’uomo nel proprio ambiente, per cui ancora si illudeva di ritrovare utopisticamente nei popoli arcaici le regole dell’abitare secondo un disegno inalterabile. E’ un peccato che Van Eyck sia stato liquidato brutalmente anziché, eventualmente, ‘decostruito’. In ogni caso, per cogliere le caratteristiche del contestualismo peculiare di queste nuove architetture impegnate a migliorare dei casi singoli sembra più adatta la dizione adottata per gli interventi di certi artisti come di opere site specific. Il prodotto architettonico, perciò, non deriva solo dalla descrizione scientifica della cultura e della società studiate dall’architetto, ma è il risultato di una “negoziazione di significati” che si svolge nelle mutevoli contingenze del lavoro sul campo, tra la personalità, il bagaglio culturale e i ruoli assunti dall’architetto e le diverse personalità e bagagli e ruoli degli interlocutori con cui egli entra in relazione.
Inoltre, a partire da questa antropologia spesso operata in prima persona dall’ ‘altro’ – molte di queste opere sono progettate da architetti locali – non possiamo più collocare questi ‘frutti impuri’ in una piena consapevolezza teorica, come parte della generale storia intellettuale della modernità, e soprattutto come produzione architettonica attraverso la quale si ristruttura la coscienza dell’Occidente. Se il neocolonialismo implicito nelle clamorose manifestazioni dell’architettura iconica e spettacolare sviluppata in varie parti del mondo per iniziativa del capitalismo transnazionale e promossa dalle ambizioni di città e paesi che gareggiano per occupare l’immaginario con edifici iconici dotati di un alto profilo figurale o gestaltico può essere inteso come ultima manifestazione dell’occidente, questi nuovi edifici, che per lo più attuano i loro programmi disponendo di risorse modeste, sono da intendere come il frutto della ricerca da parte dei nuovi architetti attivisti di un’architettura postcoloniale e come l’annuncio di una nuova fase geopolitica dell’architettura. Si tratta quasi sempre di lavori svolti da architetti poliglotti che lavorano sul posto disponendo di un bagaglio culturale raffinato, maturato anche in scuole e università di primordine del mondo occidentale, da cui si ha un trasferimento di competenze tecnologiche e culturali adatte alle situazioni incontrate che sostituiscono i vecchi criteri colonialisti basati sul trasferimento di modelli preconfezionati. La bellezza di questa architettura deve essere apprezzata anche in riferimento ai luoghi e alle persone che vediamo abitare e muoversi al suo interno: sembra una novità dopo il consumo di tante immagini di architettura che invitano alla contemplazione della pelle (skin), alle visioni notturne, al caos sublime, ecc. Pertinente allo svolgimento di questi argomenti nella 12. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2010 People meet in architecture è il suo titolo. Il richiamo a questa funzione essenziale dell’architettura, far incontrare la gente, è decisivo, anche se la mostra, inevitabilmente, forse, non lo svolge appieno. Resta tuttavia l’indicazione ed anche la scoperta che l’architettura del mondo è interessante e varia nel senso indicato da queste note. Della mostra di architettura della Biennale resta ancora l’impressione di una certa freschezza dovuta ai tanti spazi non occupati dallo star system, questa volta, alla sorpresa che questi vuoti dei padiglioni della Biennale sono riempiti da proposte provenienti in tempo reale da varie parti del mondo sinora relativamente inesplorate. Il limite della nuova situazione può essere intravisto in un certo moralismo, in chi avanza un’interpretazione dei risultati soltanto in chiave performativa, dal momento che bisogna pur dire che non vi è etica senza estetica e molti dei progetti di cui stiamo trattando trovano la loro verifica proprio nel dominio estetico. Ci piacciono, li condividiamo anche perché sono belli.
10/12/2010