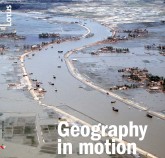in Lotus International n. 154 , 2014
L’idea di trasferire la michelangiolesca Pietà Rondanini dal museo del Castello Sforzesco di Milano in un altro luogo ha suscitato molte perplessità e una certa apprensione data la posta in gioco. La scultura cui Michelangelo diede l’ultimo tocco nel febbraio del 1564 poco prima della sua morte, fu inventariata come «statua principiata per un Cristo et un’altra figura di sopra, attaccate insieme, sbozzate e non finite». Poi l’opera fu acquistata nel 1744 dai marchesi Rondanini, da cui il nome, e all’inizio del Novecento finì dimenticata tra stracci e rifiuti nel cortile di un palazzo prima di essere riconosciuta e acquisita nel 1952 dal Comune di Milano per le Raccolte Civiche del Castello. Gli architetti BBPR che in quel tempo stavano realizzando il museo del Castello la posero a conclusione del percorso museografico da essi ideato cercando di allestire uno spazio all’altezza del capolavoro. Tuttavia, poiché per corrispondere alle odierne esigenze di valorizzazione della Pietà è previsto un trasferimento dell’opera che finirebbe per alterare l’allestimento del museo del Castello, divenuto esso stesso storico, la disputa si è incentrata nella contrapposizione tra l’allestimento e la statua. In effetti, la Pietà, essendo precluso ogni movimento, rimane nella nicchia del museo del castello e negli ultimi tempi è stata sottoposta solamente a verifiche, sollecitazioni, dislocazioni virtuali nei disegni architettonici del workshop del 1998 o nelle prove all’Ospedale del Castello condotte nel 2013 impiegando un calco. Per il dibattito in corso sui criteri espositivi museali la vicenda è molto interessante poiché gli effetti di “apertura” sull’opera michelangiolesca prodotti da queste azioni la arricchiscono di interpretazioni, senza considerare la sua attuale collocazione museografica. Ad esempio nella sua proposta del 1998 Álvaro Siza sottolinea la capacità dell’opera di costituirsi essa stessa come “luogo”, quasi ne scaturisca una spazialità cui basti far largo e dove non sono ammesse mediazioni tra opera e fruitore. Se ne deduce che per via della sua prodigiosa facoltà effusiva la Pietà potrebbe tollerare dei trasferimenti, purché sia garantito il suo magico effetto auratico. L’altra notevole indicazione proveniente dai bellissimi disegni di Siza riguarda l’assoluta individualità dell’opera, l’impossibilità di affiancarla ad altre opere come del resto avevano bene intuito i BBPR. La visita all’antica Infermeria spagnola del 1576 con il calco solitario della Pietà ivi installato sperimentalmente produce un’altra speciale esperienza emotiva. Gli effetti di rimando dalla stratigrafia dei pavimenti esistenti, dalle pareti, dai soffitti sono impressionanti, e non solo a causa dell’assonanza col non finito michelangiolesco delle numerose tracce presenti in un palinsesto tormentato, ma anche per il pathos che emana dalla sala dell’Infermeria, coeva alla Pietà, fondata per il ricovero dei castellani infetti da peste, con i suoi segni della sofferenza e della fede. Nelle intenzioni espresse nel 2013 dall’allora assessore alla cultura Stefano Boeri doveva essere un luogo di esposizione, studio, documentazione, dove la Pietà potesse sprigionare per intero la sua potenza per un grande pubblico di visitatori e appassionati. Eppure il “degrado” di un luogo non ancora restaurato, con i nitrati, i solfati, le ritenzioni di umidità, le ritenzioni sa- line degli intonaci, crea un’atmosfera incomparabile per capire certi aspetti tragici della Pietà, il suo dolore, al punto che sarebbe auspicabile conservare la scena, poterla visitare, sia pure lasciandovi soltanto un calco. L’ubicazione giusta di un’opera e la sua veridicità sono materia di antiche controversie, basti pensare al costume romano di realizzare copie delle composizioni greche più celebri, e forse è giunto il momento di iniziare a riconsiderare i criteri di autenticità di un’opera, osservarne da vicino le convenzioni fondanti, affrontare lo sviluppo storico del concetto, il senso della generazione gerarchica delle diverse dimensioni della realtà artistica. Pur senza nulla concedere ad atteggiamenti neoavanguardistici possiamo riflettere in modo utile per mettere in questione le gerarchie estetiche, sul fatto che oggi si espongono, ad esempio nei musei d’arte moderna, tanto delle opere “riproducibili” che opere “originali”. Ci chiediamo se è possibile includere nel repertorio delle “opere moderne” un calco della Pietà così come un Clone delle Nozze di Cana di Paolo Veronese al refettorio palladiano di San Giorgio Maggiore di Venezia. Una visita al celebre refettorio veneziano, memori di un certo fastidio provato in precedenti sopralluoghi a causa delle manchevolezze dello spazio architettonico, vittima di una spoliazione operata con la violenza e l’inganno, ci fa incontrare con gioia il clone del Veronese. La meraviglia nell’avvicinarsi alla “crosta” dell’immenso telero supera ogni altra considerazione e, pur essendo informati della sua costituzione artificiale, non ci arrestiamo di fronte all’“inganno” che sta di fronte a noi. Nel settembre 2007, a Venezia è accaduto un evento straordinario. Dopo 210 anni di assenza, le Nozze di Cana “sono tornate” dal museo del Louvre nella loro sede originaria nel Cenacolo Palladiano dell’isola di San Giorgio Maggiore grazie alla creazione di un “secondo originale”, ossia un fac-simile in scala 1:1 ottenuto con le più sofisticate tecniche di riproduzione e realizzato con le tecnologie sviluppate da Adam Lowe, artista britannico fondatore dell’atelier Factum Arte, laboratorio all’avanguardia nella ricostruzione e riproduzione di opere d’arte. Mentre a Venezia si celebra lo shock estetico dovuto alla ricostruzione “dov’era e com’era” che organizza il ritorno “a casa” di una creatura con le fattezze dell’originale, in altre circostanze la rivitalizzazione dell’opera avviene agendo per modificare i piani di lettura. In questi casi i metodi interpretativi dell’arte, nelle mani “creative” di critici, artisti, registi teatrali e cinematografici, vengono usati per “aprire” l’opera a nuove avventure rompendo con i modelli di comunicazione e i canoni espositivi consueti. A Venezia la scoperta di non trovarsi di fronte all’originale è di tipo cognitivo e non percettivo, si basa sul fatto che sappiamo già del clone, mentre al museo di Brera di Milano la scoperta dell’installazione di Ermanno Olmi per il Cristo Morto di Mantegna è di tipo percettivo e si basa sul confronto con le abitudini espositive conosciute o con il ricordo della sistemazione precedente. A Brera ci troviamo immersi nel Mantegna interpretato da un maestro del cinema come Ermanno Olmi che colloca l’opera in una sequenza spaziale coinvolgendo anche la Pietà di Giovanni Bellini mentre «la necessità di esaltarne il valore spaziale – secondo un insegnamento che Andrea Mantegna trasse da Leon Battista Alberti – ha suggerito l’eliminazione della cornice, documentata del resto solo a partire dal XVI secolo. Il Cristo Morto è così sistemato a 67 centimetri dal suolo». L’allestimento isola nell’ombra e distanzia il dipinto in accordo con la particolare forzatura prospettica e cromatica che lo caratterizza. Infatti «i dolenti raffigurati a sinistra, pensati in una visione reale in posizione inginocchiata, impongono una collocazione ribassata rispetto alle altre opere del museo». Sicuramente Olmi intende produrre un effetto di realtà e insieme un luogo di meditazione per cui il Cristo di Mantegna è meglio se esiste senza la cornice, anche se senza la cornice una raffigurazione resta una raffigurazione, e nulla mette effettivamente in questione la sua natura di oggetto immaginativo. Se vogliamo, la modernità dell’atteggiamento di Olmi è nel non riconoscere la funzione propedeutica della cornice nella ricezione della raffigurazione in quanto tale. Dunque il rimescolamento operato da Olmi agisce sulle convenzioni museografiche per introdurre un messaggio capace di agire sull’inerzia del pubblico rimanendo tuttavia al servizio dell’opera, senza rovesciare i termini del problema. Una clamorosa abrasione dell’intera “cornice” museografica, quella cornice rappresentata dall’architettura, è avvenuta a Lens nel nordest della Francia col progetto del Louvre Lens, di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (SANAA), costituito da cinque bassi edifici con un rivestimento esterno in alluminio anodizzato e vetro che si riflette e si fonde con l’ambiente sino a sparire nel paesaggio. Lo stesso effetto di sparizione si trova all’interno, come ad esempio nello spazio unitario della Grande Galerie du Temps di 3000 mq concepita come un percorso cronologico attraverso le culture artistiche dal 3500 avanti Cristo all’inizio del XIX secolo. Alla Galerie del Louvre Lens le convenzioni museografiche sono messe in discussione dalla collocazione a terra delle opere disposte quasi su un piano archeologico sul quale il pubblico circola liberamente mentre la luce filtra dalla copertura del padiglione e lo spazio si dissolve sul bordo delle pareti per effetto del riverbero del rivestimento in alluminio. In questo caso il rimescolamento delle convenzioni museografiche è opera di Célia Imrey e Tim Culbert ed è reso possibile dal fatto che l’architettura si limita a offrire un’impercettibile funzione protettiva come avviene in certi esempi di copertura delle zone archeologiche. Nel grande parterre della Galerie sembra di assistere a un omaggio allo spazio museale immaginato a suo tempo da André Malraux, il famoso Musée imaginaire, che a Lens si materializza nei principi iconologici dell’Atlante, dell’Archivio, ecc. Più precisamente nel grande parterre di Lens la forma specifica del sapere sul mondo e sulla sua storia passa attraverso il montaggio di immagini sulla scia della tradizione di Aby Warburg e di Walter Benjamin, insomma della costellazione degli autori amati da Georges Didi-Huberman. Perciò l’abbandono della parete quale luogo dedicato all’appendimento, come nel caso di Lens e, in generale, la rinuncia alla cornice, compresa quella offerta dai soliti contenitori museografici, nel mettere in discussione le classificazioni abituali, può avere tanto degli effetti di rigenerazione e di ricomposizione del patrimonio quanto produrre smarrimenti e confusioni così come avviene in tutte le fasi di reinterpretazione di una determinata organizzazione del sapere.